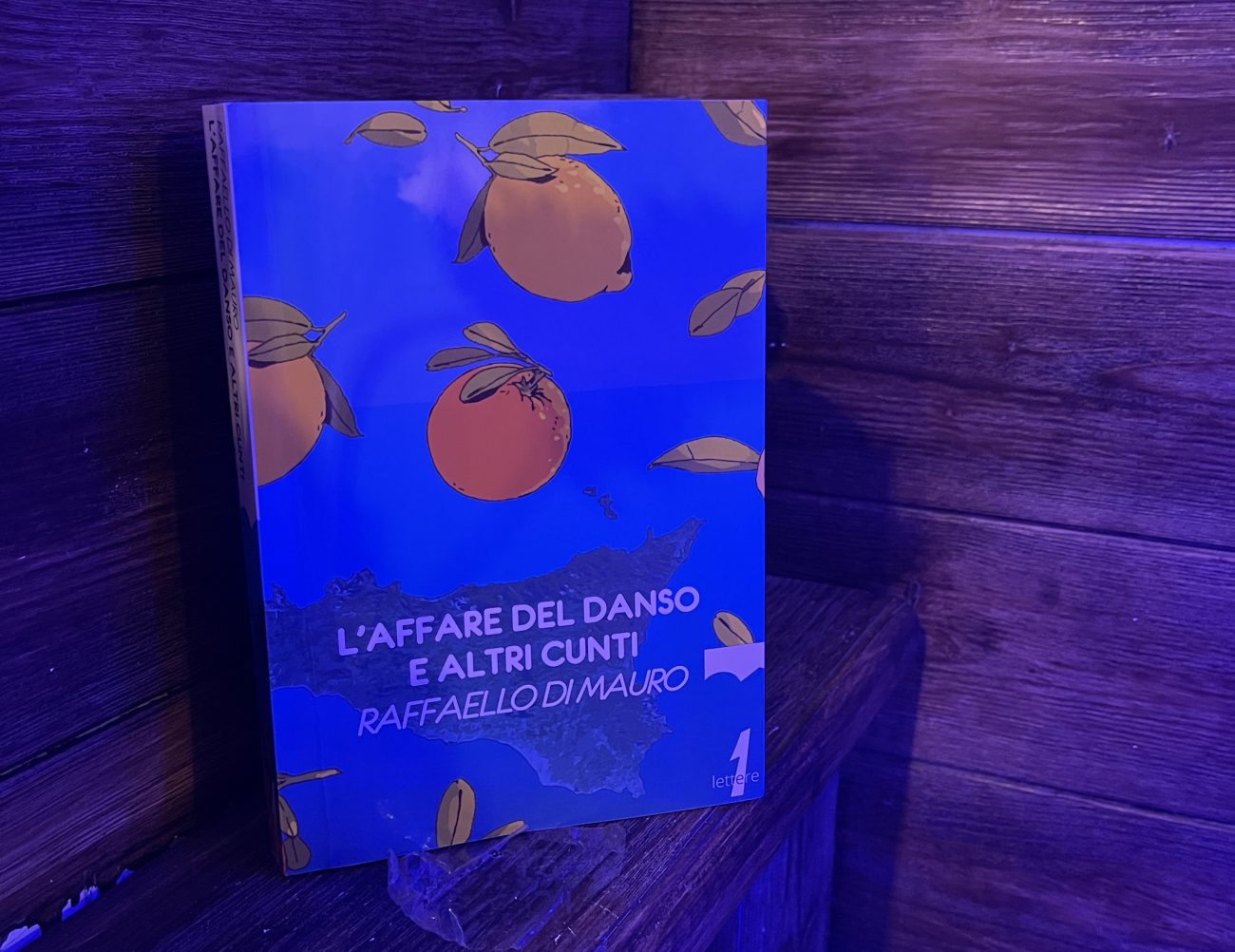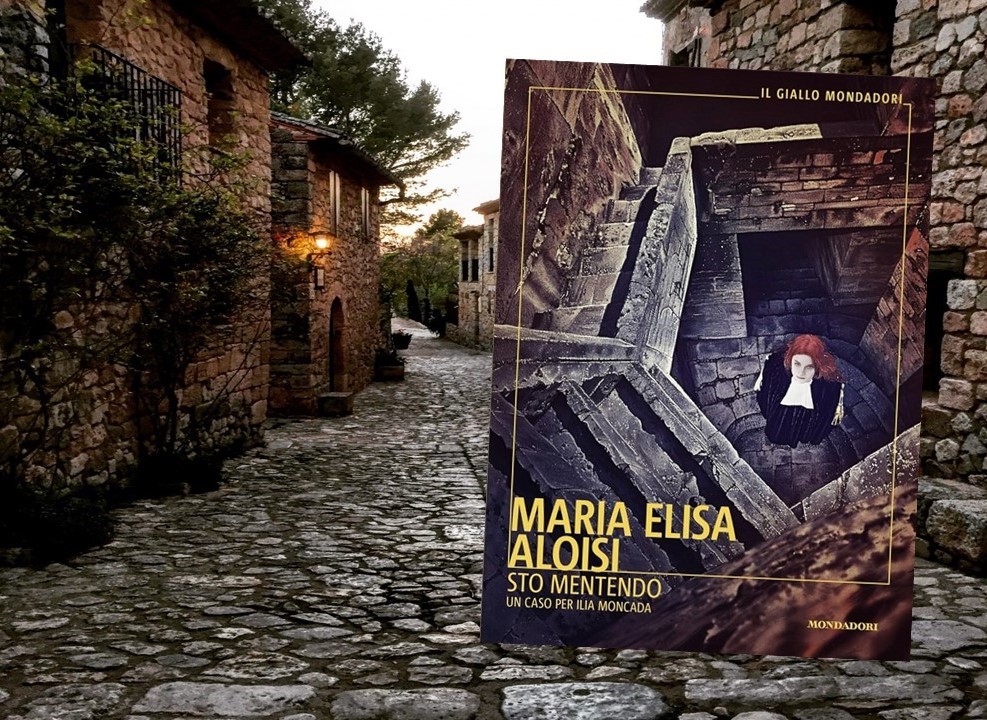Di Oriana Ramunno
Dalla quarta di copertina
Quando Hugo Fischer arriva ad Auschwitz è il 23 dicembre del 1943, nevica e il Blocco 10 appare più spettrale del solito. Lui è l’investigatore di punta della Kriminalpolizei e nasconde un segreto che lo rende dipendente dalla morfina. È stato chiamato nel campo per scoprire chi ha assassinato Sigismud Braun, un pediatra che lavorava a stretto contatto con Josef Mengele durante i suoi esperimenti con i gemelli, ma non ha idea di quello che sta per affrontare. A Berlino infatti si sa ben poco di quello che succede nei campi di concentramento e lui non è pronto a fare i conti con gli orrori che vengono perpetrati oltre il filo spinato. Dalla soluzione del caso dipende la sua carriera, forse anche la sua vita, e Fischer si ritroverà a vedersela con militari e medici nazisti, un’umanità crudele e deviata, ma anche con alcuni prigionieri che continuano a resistere. Tra loro c’è Gioele, un bambino ebreo dagli occhi così particolari da avere attirato l’attenzione di Mengele. È stato lui a trovare il cadavere del dottor Braun e a tratteggiare la scena del delitto grazie alle sue sorprendenti abilità nel disegno. Mentre tutto intorno diventa, ogni giorno di più, una discesa finale agli inferi, tra Gioele e Hugo Fischer nascerà una strana amicizia, un affetto insolito in quel luogo dell’orrore, e proprio per questo ancora più prezioso.
Recensione
“Il bambino che disegnava le ombre” è un giallo classico, in cui abbiamo l’investigatore impegnato a risolvere un caso di omicidio, costretto a districarsi fra indizi ‒ alcuni creati ad hoc per depistarlo, altri sapientemente nascosti ‒, false piste e diversi sospettati, tutti con un movente più che valido ad armarne la mano. Vista così, potrei continuare dicendo che la trama è ben congegnata, che il colpevole rimarrà un mistero per il lettore fino al colpo di scena finale, che il ritmo è abbastanza sostenuto da non rendere noiosa la lettura. E sarebbe una critica positiva.
“Il bambino che disegnava le ombre” però è più di questo e il plus è l’ambientazione.
Il nostro investigatore classico, il brillante criminologo berlinese Hugo Fischer, è chiamato a indagare sull’omicidio di un medico genetista, Sigismund Braun, costretto a ingoiare una fiala di cianuro alle porte del Natale del 1943. In piena Seconda Guerra Mondiale, sì; ma non è solo questo: l’omicidio è avvenuto all’interno del campo degli orrori per antonomasia, Auschwitz. L’emblema della miseria dell’Umanità, del punto più basso e ignobile che l’Uomo sia riuscito a toccare in pieno XX secolo, il cosiddetto “secolo del progresso”.
La storia che Oriana Ramunno ci racconta allora si sdoppia: abbiamo lo sviluppo dell’indagine ‒ svolta da Hugo Fischer avvalendosi dello spiccato spirito di osservazione e della formidabile intelligenza di Gioele ‒ all’interno della cornice della Storia, che è la nostra storia recente, la storia che possiamo ancora ascoltare per bocca dei nostri nonni e da cui evidentemente ˗ permettetemi la digressione ˗ non abbiamo imparato nulla, se proprio in questi giorni l’Afghanistan è di nuovo nella mani dei talebani.
La conosciamo, l’abbiamo studiata, ma riviverla attraverso gli occhi di Hugo e Gioele è un’altra cosa.
Fa male.
Spezza il fiato.
Perché la scrittura della Ramunno è precisa, chirurgica: ti costringe a guardare anche quando vorresti voltarti dall’altra parte. Non solo: ti dà il dolce e l’amaro. Mi hanno molto colpita le descrizioni paesaggistiche: la coltre di neve che tutto ovatta, il bosco di betulle, l’ambientazione da presepe che ti farebbe quasi rilassare se non fosse che poi, insieme ai fiocchi candidi, dal cielo scende giù la cenere che proviene dai forni crematori. E lì ti arriva uno schiaffo in faccia.
La storia è narrata per bocca di Hugo Fischer e di Gioele.
Hugo è un nazista “di comodo”: era un vigliacco, un arrivista che aveva sacrificato la propria morale alla carriera. Si teneva in equilibrio sul filo precario di ciò che si poteva e non si poteva dire, di ciò che si poteva e non si poteva fare. Vestiva i simboli nazisti per pararsi dietro di loro come uno scudo. “Sei un disgraziato” gli avrebbe detto sua madre se fosse stata ancora in vita.
Gioele è un ebreo italiano: la sua “fortuna” è essere un gemello. Anziché passare direttamente dal treno merci alla camera a gas, la sua vita per il momento è stata prolungata perché possa fare da cavia, insieme al fratello, per gli esperimenti del dottor Mengele.
Discesi all’inferno, scopriamo che anche lì, contro ogni logica e aspettativa, possono nascere sentimenti quali amore, affetto e amicizia: il rapporto tra Hugo e Gioele è di una dolcezza disarmante, ma anche tanti piccoli grandi gesti che altri personaggi compiono sono quella goccia che, “in un oceano di sterco”, fa la differenza.
Hugo risolve il caso, in un modo che fuori da lì non avrebbe mai preso in considerazione, ma non è lo stesso uomo che una settimana prima è entrato ad Auschwitz: adesso la sua visione del mondo è totalmente cambiata. E noi lasciamo il campo con lui: con il cuore grondante dolore, dopo aver ascoltato tante di quelle promesse che non sapremo mai se poi si saranno realizzate. Perché Auschwitz è una bocca che ingoia il futuro, che non lascia speranza, e se dici a qualcuno che ami: «Aspettami, quando tutto questo sarà finito ti raggiungerò», sai già che non potrai mantenere fede alla parola data.
La conosciamo questa Storia, l’abbiamo studiata, ma riviverla attraverso gli occhi di Hugo e Gioele è tutta un’altra cosa.
Claudia Cocuzza