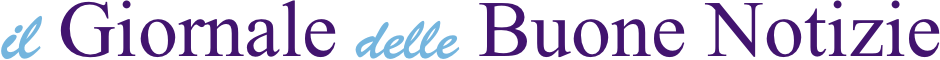L’Isola della Verità
Un potente dittatore regnava in un’isola sperduta nell’Oceano Pacifico, un piccolo stato indipendente, ma relativamente ricco. Le risorse naturali della terra unite alla bravura degli abitanti nel lavorare il legno, nello scolpire la creta, nell’Arte Scultorea, nella Pittura e nella Musica, ma, soprattutto, nella lavorazione di pietre particolari, e unite all’abilità commerciale del dittatore, favorivano vantaggiosi scambi con il resto del mondo.
Il dittatore era autorevole, ma non cattivo, non ce n’era bisogno. Gli abitanti erano ligi al loro dovere, lavoravano alacremente, si rispettavano a vicenda e, soprattutto, obbedivano, assecondavano, quasi veneravano colui che aveva portato loro quel benessere, così, quasi all’improvviso, sottraendoli alla mediocrità e piattitudine di una vita agricola e peschereccia. Una comunità apparentemente perfetta, sempre attiva, equilibrata, tutto questo da quando lo Straniero era giunto alla loro terra, dal mare, sfinito, esausto.
Come direbbe un giornalista famoso: “Ma facciamo un passo indietro”. Lo straniero, approdato in questa terra, divenuto poi il governatore di questa gente, nella sua nazione di provenienza era un bravissimo imprenditore, un egregio organizzatore e gestore di affari, risorse umane e finanziarie. Un uomo di successo. Ma aveva chiesto troppo alle sue capacità: non soddisfatto delle ricchezze accumulate, iniziò la scalata al potere abbracciando la politica, sfruttando la sua potenza economica, le sue influenze e conoscenze altolocate. Ma alla fine la situazione gli era sfuggita di mano: era oramai circondato da nemici o, peggio, da falsi amici, demagoghi e iene senza scrupoli, che ben presto lo costrinsero all’esilio.
A favorire il crollo del suo impero economico e politico aveva contribuito il suo vizio: le donne. Più andava avanti con gli anni, più si circondava di giovani e fresche arriviste dalle “vedute” fin troppo larghe. Diventato vittima di ricatti, zimbello della popolazione, ridicolizzato agli occhi del mondo, fu abbandonato anche dalla sua famiglia. Messo alle strette, dopo aver pagato invano centinaia di migliaia di dollari agli avvocati, prima di dover rendere conto alla giustizia, decise di fuggire dalla sua patria e rifugiarsi all’estero. Ma nessuno stato del mondo voleva dargli asilo, neppure il Brasile. La sua impopolarità si era propagata in tutto il pianeta, si era ridicolizzato al punto di diventare oggetto di scherno, protagonista di vignette comiche e barzellette in tutte le lingue.
Passando le ore sul mappamondo trovò un’isola sperduta nel Pacifico che risultava essere inesplorata, indicata col nome “Isola della Verità”, della quale si sapeva ben poco.
Fece una ricerca su internet e si accorse che di tale luogo si narrava solo nelle favole, pochi esploratori erano riusciti ad addentrarsi, ma preferirono allontanarsi. Altri non fecero ritorno. Fra le notizie rintracciate emergeva si trattasse di una comunità anarchica, i cui abitanti riuscivano a vivere in perfetta armonia da secoli senza evolversi, ma senza nemmeno regredire. Gli indigeni erano calmi e onesti: nessuna rissa, nessuna ostilità, niente criminalità. Non effettuavano dunque scambi commerciali con la terraferma. Vivevano di pesca, agricoltura e caccia, nella loro terra fertile e florida, e non cercavano di più. Un vero Paradiso Terrestre.
Ma non era facile approdarvi per qualunque turista, nè tantomeno soggiornarvi a lungo: gli abitanti anche se non erano ostili, non accettavano visite, e, in maniera elegante, scoraggiavano la permanenza anche breve di qualunque estraneo curioso. Il nostro uomo decise comunque di recarsi là: era sicuramente l’unico posto della terra al quale, per forza di cose, fosse sconosciuto e dove avrebbe potuto nascondersi.
Presto detto presto fatto, avrebbe forse passato la sua vecchiaia in quel paradiso, senza pensieri, senza contrasti, senza ansie, ma, soprattutto, senza politica: il mito della comunità perfetta. Naturalmente aveva maturato un piano, sia per scomparire dalla società civile, sia per farsi accettare nella nuova comunità.
Puntando ancora una volta sulle sue indiscutibili capacità, raccolse tutti suoi risparmi liquidi, una somma più che sufficiente a chiunque per vivere senza lavorare, ne depositò una parte in un conto occulto, e tenne il resto per le spese. Prese il suo aereo personale, fornì le coordinate al suo pilota personale, una persona estremamente fidata, forse l’ultima rimastagli, che lavorava per lui da oltre trent’anni, e si recò lì, in quella isola sperduta.
Un principio di uragano costrinse il pilota a risalire di quota, e il nostro uomo decise di farsi paracadutare sull’isola, insieme alla sua scorta di viveri, la tenda e tutti gli oggetti al seguito, con grandi difficoltà a causa del vento forte. Salutò il pilota:
“Va fedele e fidato amico, torna a casa, e non dire ad alcuno che sono qua, ne va della mia vita, tranne a mio figlio, il mio piccolo orgoglioso e saggio Andrea, quello che mi ha sempre voluto bene e non mi ha mai chiesto soldi. Non preoccuparti per me, me la saprò cavare, come ho sempre fatto. In premio per la tua fedeltà e amicizia ho disposto un piccolo vitalizio per te e la tua famiglia. Dì pure a mio figlio che può accedere al mio conto occulto, lui e nessun altro, ma solo quando ne avrà estremamente bisogno. Le coordinate sono in questa busta che ti affido, sicuro della tua onestà. Addio fedele dipendente, amico, va e non tornare più”.
Il pilota, lacrime agli occhi, attese che il suo datore di lavoro si lanciasse col paracadute, poi virò e si allontanò scuotendo la testa. Visibilmente commosso e addolorato, riprese il volo facendo ritorno nel suo Stato di provenienza.
Il nostro uomo, che da questo momento chiameremo “l’esiliato”, atterrò dolcemente in mare, non lontano dall’isola, mentre tutte le sue masserizie, raccolte in un grosso pacco appeso all’altro paracadute, caddero sull’isola, non lontano dalla spiaggia, toccarono terra, ma dolcemente. Il paracadute rimase impigliato ai rami di un albero, rallentando la caduta: anche questa fu una fortuna poiché il vento non le avrebbe trascinate via insieme al pacco.
Lui, l’esiliato, riuscì a liberarsi del proprio paracadute in mare e, faticosamente, riuscì a raggiungere la spiaggia dell’isola. Stremato, ebbe la forza di raggiungere ed aprire il pacco di sopravvivenza attaccato al paracadute impigliato, riuscì a recuperare la tenda, i viveri e tanti altri oggetti, ma niente radio, niente TV: tutto perduto in mare. Nessun problema, poiché non sarebbe stato possibile ricevere alcun segnale. Il cellulare satellitare che aveva portato con sé era fuori uso, ma meglio così: non avrebbe avuto ripensamenti. Niente “ordigni” tecnologici dunque, perduti in mare o comunque inutilizzabili: anche questa la considerò una fortuna. Nel pacco di sopravvivenza erano rimasti, oltre ai viveri, il materiale per dipingere, gli strumenti per scolpire, un po’ di creta, un po’ di legno, la sua vecchia chitarra intatta. La fortuna alla fine gli era stata ancora amica: si era ripulito delle cose inutili ed avrebbe potuto riprendere a coltivare a tempo pieno le sue vecchie e quasi dimenticate passioni.
Il nostro esiliato, malgrado fosse esausto, cominciò a montare la tenda, a disporre i suoi oggetti, a preparare il suo spazio vitale con vista sul mare, sotto gli occhi curiosi e non troppo contenti di alcuni indigeni che, in un primo momento, decisero di tenerlo d’occhio senza farsi scorgere. Accese un fuoco con un accendino (che era miracolosamente rimasto asciutto) per asciugarsi e prese a scaldare i viveri di scorta, mangiò, poi imbracciò la chitarra e si mise a cantare e suonare, come non faceva più da immemori anni. La sua voce non aveva perso tono, anzi, si era addolcita, e la chitarra lo accompagnava dolcemente. Fin quando crollò, esausto per la stanchezza e lo stress, riuscendo appena a svestirsi e infilarsi nel sacco a pelo.
L’ “Isola della Verità” era situata in pieno Tropico del Cancro, in mezzo all’Oceano Pacifico, clima mite 12 mesi l’anno e l’escursione termica fra il giorno e la notte di soli quattro gradi, poca ventilazione, ma costante. Si rinchiuse nel suo sacco a pelo dentro la sua tenda e si addormentò.
Così, si risvegliò il giorno dopo, sgusciò dalla tenda, si alzò, si stiracchiò, un sole stupendo, una meravigliosa visuale del mare e… sorpresa: una decina di indigeni intorno a lui, truccati di tutti i colori, poco vestiti e agghindati di frasche, piume e collane di pietre colorate e luccicanti.
Dopo un primo momento di panico istintivo, che lo induceva a scappare, presto represso (non c’era alcun posto dove scappare), si fece avanti alla volta di colui che sembrava essere il capo, il più agghindato di tutti e anche il più anziano, e cercò di spiegarsi a gesti e mugugni:
“Io… straniero… donare cose da aquila volante… fame… mangiare”
L’indigeno scoppiò in una risata e ribattè:
“Tranquillo straniero, io parla poco tua lingua ma capire bene. Noi non volere stranieri… noi felici… mondo dietro il mare cattivo. Miei genitori, tris-tris-tris nonni, venire da America tanto, tanto tempo passato, naufragati e noi rimasti qui, cresciuti così, fraternizzato con indigeni, felici. Cosa volere tu qui?”
Tirò un sospiro di sollievo, sapeva di poter essere compreso, ma la sua prosopopea, le sue tattiche dialettiche e tecniche ammalianti sarebbero state inutili: sapeva che doveva ricorrere all’umiltà per sopravvivere.
“Io sono naufrago, non volere dare fastidio, volere solo lavorare per voi per mangiare e vivere”
L’indigeno, incuriosito dalla chitarra, gli domandò
“Cosa essere quell’arma che manda suoni che incanta? Una stregoneria?”
“Noooo” – rispose sorridendo, ma composto, il nostro esiliato – “non è un’arma, questa è una ‘Chitarra’, che manda musica se la si accarezza dolcemente con le dita, per relax, per gioia, per allegria.”
Iniziò una musica melodica, arpeggiata, e prese poi a cantare. Piano piano altri indigeni gli furono attorno e osservavano, ascoltavano, ipnotizzati da quella melodia. Poi il nostro uomo attaccò una musica più ritmica, stile rock, ma non esagerata. D’istinto un indigeno iniziò a ballare, un altro prese due rami e cominciò a battere su un tronco di legno cavo. Altri seguirono l’esempio del primo, altri iniziarono a battere le mani e tutti insieme passarono ore di magia musicale, un’emozione pressoché sconosciuta a quegli indigeni doc e d’importazione, sempre occupati a lavorare, mangiare, oziare, riprodursi.
Il capo decise di fermare musica e danze non appena il sole crebbe verticale sulle loro teste, con un cenno, al quale tutti ubbidirono istantaneamente, compreso il nostro esiliato.
“Straniero, tu porta allegria in mio popolo con tua musica e tutti noi gradire. Tu mangiare con noi sempre e tu sempre fai musica”
Oramai la pellaccia era salva, anzi, il primo passo di socializzazione si era consumato nel migliore dei modi. Ma quale sarebbe stata la prossima mossa? L’idea di strapazzare la chitarra per tutto il resto dei suoi giorni era tutt’altro che allettante, ma al momento il problema nutrimento era risolto, al resto ci avrebbe pensato poi, a pancia piena. Ottimi i pasti, niente carne, solo frutta e verdura, acqua pura, dolciastra, di oasi.
Durante il pasto non mancò di socializzare, chiacchierare con il capo, nonché di “osservare” la componente femminile della popolazione, tutt’altro che sgradevole, anzi, ottimo motivo di risveglio dei sensi. Oramai si sentiva a suo agio, e con nuovi stimoli, ma si sentì in obbligo di fare qualcosa di più per questa popolazione che lo stava ospitando nel migliore dei modi. E osservava il modo di vivere di questa gente, il loro sapersi accontentare di poco e niente, di quello che la natura poteva loro offrire: ben poco, rispetto ai suoi standard. Presto si sarebbe annoiato. Non che gli mancasse il suo mondo di provenienza, anzi qui era al sicuro, però la sua indole si ribellava dal più profondo di se stesso. E cominciò a pensare, come cambiare la sua vita compatibilmente con l’equilibrio di quel mondo.
La notte gli portò consiglio, e si risvegliò con un’idea fulminante: avrebbe aiutato questi indigeni a migliorare la produttività per concedersi un pò di tempo allo svago. Chiese di essere ricevuto dal capo, per illustrargli la sua proposta, e presto fu da lui ricevuto.
“Questa essere creta, per scolpire, per creare pentole, per cuocere meglio i cibi, per fare brodo oppure per plasmare forme e abbellire gli interni. Poi si scalda su fuoco, diventa terracotta e così si può decorare con questi pennelli per dipingere e questi sono i colori. Io vi posso insegnare a scavare nel fango per trovare la creta, vi insegnerò a lavorarla e a cuocerla per fare tubi per portare meglio l’acqua nei campi. Questo è legno lavorato per fare tavolo, per mangiare più comodi, vi insegnerò a lavorare il legno e…”
E per quanto volesse essere sintetico ed elementare, il capo lo interruppe, non capiva niente e disse:
“Straniero, tu essere sicuro armato di idee buone, ma noi non capire. Io dare te fiducia, tu avere portato la voce della gioia in mio popolo e tu volere aiutarci. Se tu essere d’accordo io nominare te Consigliere del Sovrano: essere una investitura difficile, che non vuole nessuno, hanno provato pochi altri stranieri prima di te, nessuno riuscito, tutti fallito: non erano buoni. Essere tu pronto? Pensare: tu potere morire e io… noi… non potere aiutare”.
“E che sarà mai?” – pensò fra se e sé il nostro imprenditore esiliato, lui che aveva affrontato mille perigli nella sua carriera, rischiato la galera mille volte, e mille volte sgusciato come un’anguilla, aveva affrontato situazioni e persone pericolose, furbi, mafiosi, banditi e giudici agguerriti. Come avrebbero potuto un pugno di uomini innocenti e genuini procurargli pericolo? Specialmente dopo tale benevola accoglienza?
Così assecondò il sovrano e si lasciò mettere al collo una strana collana, costituita di anelli di bellissime pietre colorate e riflettenti.
“Tu straniero essere nominato Supremo Consigliere, dovrai scrivere leggi e governare nostro popolo, la collana che indossi da questo momento ti accompagnerà per sempre, come la tua ombra, la tua coscienza. Sarà dolce e danzante con te quando farai buone cose, sarà amara e punitiva quando il tuo operato non essere per il bene di tutti noi. Sarai rispettato, onorato e obbedito, ogni tuo desiderio essere ordine, ma dovrai fare sempre cose buone per noi tutti e per te stesso”.
Salutò con un bell’inchino e se ne andò per riposare. La collana gli piaceva, si guardava allo specchio, era molto bella, di pietre colorate, dure e luccicanti come diamanti, forse doveva avere un gran valore: non aveva mai visto prima d’ora quel tipo di minerale, e lui se ne intendeva. Prima di addormentarsi cominciò a pensare fra sé e sé: “Sicuramente queste pietre si troveranno nel sottosuolo, non esistono in nessun angolo della Terra. Potrei far scavare una miniera, poi vendere il minerale grezzo al mondo esterno, comprare degli strumenti per la lavorazione di queste pietre, per poi rivenderle a dieci volte il ricavato dal grezzo, e questa gente oltre ad avere un lavoro più dignitoso e meno faticoso potrebbe costruirsi una casa più bella, più riparata, avere del tempo libero, giocare più tempo con i figli…”
Mentre elaborava questi piani, la collana sembrava luccicare di luce viva e danzare intorno al suo collo, lo accarezzava anche dietro la nuca favorendo il suo sonno e così si addormentò dolcemente.
Come finirà questa favola? Leggi la seconda parte nel prossimo articolo
Vincent
Scrittore, Musicista, Informatico
Tratto dal racconto n. 8 del mio primo libro “Le Favole di Vincent”